Pensare allo sviluppo del Nordest in chiave socioeconomica richiede necessariamente di tener conto anche dell’aspetto turistico, che è poi una delle modalità di fruizione principali del territorio e, insieme, anche un elemento addirittura identitario dello stesso, soprattutto in alcune zone specifiche.
Il Nordest è una delle prime destinazioni per turisti nazionali ed internazionali e molte delle destinazioni tematiche presenti rappresentano oramai un riferimento nel contesto turistico europeo. L’evoluzione di questo mercato a livello globale evidenzia, tuttavia, come nel prossimo futuro il mantenimento di tale attrattività si giocherà sempre più sull’abilità di territori e destinazioni a raccontarsi, a intercettare una domanda multidimensionale e digitalizzata. L’utilizzo strategico delle nuove tecnologie può addirittura dare vita a nuovi ed inediti modelli di fruizione turistica, ridefinendo i confini della domanda e dell’offerta e lasciando molto spesso al turista la libertà di scegliere luoghi, tempi e modalità di viaggio.
In questo scenario, per molti versi sfidante ma anche complesso, dobbiamo anzitutto chiederci due cose e cioè: 1) perché sia importante considerare il turismo - anzi meglio, l’industria turistica - una leva importante nello sviluppo di territori così ampi e diversi tra loro e 2) perché sia importante farlo attraverso l’esame delle policy tracciate dalle singole Regioni.
Turismo quale leva di sviluppo
Il turismo si propone come un fenomeno economico trasversale che incide direttamente e indirettamente su tutti gli altri settori dell’economia, creando un indotto benefico esponenziale.
Per coglierne le potenzialità occorre, però, attivare una filiera virtuosa che vede il Turismo come una industria che richiede una precisa organizzazione.
Nella pianificazione strategica del turismo,
l’aspetto dell’integrazione è pervasivo e molto rilevante: riguarda gli oggetti (risorse, territori, temi), i processi produttivi, i soggetti del sistema del turismo.
Gli esiti dell’analisi di impatto del settore del turismo italiano sul PIL nazionale, così come calcolati dal modello del World Travel and Tourism Council nel 2018, ci dicono che la quota di PIL nazionale totale generata dal turismo risulterebbe pari all’11,8% (171 miliardi di euro) e l’impatto sull’occupazione sarebbe attorno al 12,8 % (3,1 milioni di unità di lavoro). Sono dati importanti, la cui valenza appare ancora maggiore per Regioni quali Veneto, Trentino-Alto e Friuli-Venezia Giulia: territori per loro natura prevalentemente turistici. L’area geografica coperta dal Rapporto di Fondazione Nord Est, per altro, presenta da tre anni a questa parte un aumento considerevole dei flussi turistici, sia interni che internazionali.
Le policy regionali dedicate: importanza e fotografia aggiornata
Ma perché sono importanti le policy di sviluppo turistico regionale e, solo cambiando verso, perché una Regione dovrebbe dotarsi di una policy per il turismo?
Innanzitutto, per il fatto che la competenza in materia turistica è esclusiva delle Regioni. E ancor più se ci si concentra su quattro brevi riflessioni che mettono a fuoco i vantaggi e le opportunità derivanti da una chiara politica che sottintende una visione condivisa e di medio periodo.
1. La prima è che la formazione di una policy specifica attesta in modo inequivocabile la consapevolezza del turismo quale industria per lo sviluppo di un territorio. Essa policy conferma con i fatti quello che spesso è solo una mera affermazione di principio: una sorta di mantra che non valica la soglia degli eventi e convegni nei quali è pronunciato. Costruire una policy comporta un cammino spesso lungo, composto da un confronto articolato con stakeholders ed operatori, contraddistinto da una fotografia ragionata (non meramente statistica) del territorio e dalle sue reali capacità attrattive e molto altro ancora: insomma un percorso analitico e che ha quale output l’indicazione di priorità ed obiettivi pluriennali.
2. La seconda ragione è che tramite la policy si possono attivare percorsi che trasformino il capitale iniziale di un determinato territorio (patrimonio storico, architettonico, paesaggistico/naturalistico) in fonte di vantaggio comparato. Non si tratta più solo di promuovere quasi passivamente le bellezze che si hanno, quanto piuttosto di elaborare traiettorie che consentano di valorizzare tutto questo in termini di incoming turistico e, più in generale, di sviluppo. In questo la destinazione rivela appieno la sua identità: non basta sostenere di avere coste (o laghi o monti...) meravigliosi, ma serve organizzare tutto questo secondo principi di managerialità.
3. La terza ragione è che solo se vi è una policy strategica si possono impiegare con coerenza le risorse dedicate al settore, siano esse di provenienza UE o interna. È infatti evidente come le azioni ed i conseguenti bandi per l’impiego di risorse trovino una maggior utilità e coerenza se rivolti a conseguire obiettivi di crescita di mediolungo periodo. Si fa al proposito notare, per altro e con riferimento alla Programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali UE, una certa convergenza nelle previsioni di impiego delle risorse tra le Regioni considerate, essendo queste ultime rivolte per lo più alle seguenti voci: miglioramento dell’offerta ricettiva, progetti di promozione della destinazione o club di prodotto, valorizzazione delle risorse naturali/storiche/architettoniche e start up di imprese turistiche.
4. La quarta ragione risiede nel fatto che solo tramite una policy condivisa è possibile stabilire una governance efficace del (e per il) settore. La scelta da parte di una Regione di istituire una agency ad hoc oppure di riconoscere plurimi organismi di gestione delle destinazioni oppure, ancora, di lasciare in vita una serie frammentata di soggetti con natura giuridica e scopi diversi, da cosa può mai dipendere se non da un disegno di sviluppo che sta a monte
Traiettorie, convergenze, risorse: qualche riflessione
Leggendo nel dettaglio i diversi piani regionali (riportati nelle schede successive) si colgono traiettorie comuni e convergenze che consentono di sottolineare come negli ultimi anni si sia registrata, finalmente, una maggiore consapevolezza della necessità di programmare, definire e governare il turismo come reale risorsa di sviluppo dei territori.
Garantire al turista un’offerta Integrata
Una prima traiettoria comune è quella di garantire (al turista) un’offerta integrata. Nelle aree a maggior vocazione turistica, questa traiettoria appare ancora più spinta, palesando addirittura la volontà di “trasformare” il territorio in un sistema turistico integrato. Il turismo viene visto come fattore di integrazione (culturale, storica, naturalistica) ma, al tempo stesso, la destinazione turistica integra al proprio interno una molteplicità di prodotti fruibili dal turista.
Individuare temi su cui focalizzare gli interventi
Una seconda traiettoria è quella di selezionare una serie di assi o temi prioritari su concentrare l’offerta e dunque le iniziative di marketing. Sembrerà un dato scontato e perfino banale, ma in realtà non è proprio così. Per anni, infatti, non si può negare che una certa dote di spontaneismo abbia caratterizzato il turismo e persino la sua pianificazione. Porsi per obiettivo la trasformazione del territorio con un significato di attrazione turistica significa, come detto, parlare di destinazione, di tematismo turistico. In alcuni casi, il concetto di destinazione è talmente assorbente, da ricomprendere la stessa denominazione di ampie aree regionali: è il caso della “destinazione turistica Emilia “, composta dalle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che danno vita ad un circuito integrato tra enogastronomia, cultura, città d’arte, etc.
Affidare la governance a un soggetto dedicato
Una terza traiettoria riguarda la governance. Praticamente tutte le Regioni considerate hanno sposato una modalità di destination management organization: per il tramite di un Agency ad hoc oppure per mezzo di vere e proprie Organizzazioni di destinazione. Quale che sia la scelta operata, possiamo fotografare il superamento del vecchio e frammentato sistema in cui, spesso senza un reale coordinamento, coesistevano agenzie di promozione, pro loco, associazioni, uffici turisti, consorzi di promozione e tanto altro ancora.
Utilizzare il digitale per la promozione
Una quarta traiettoria concerne l’utilizzo del digitale in chiave di promozione. Il Veneto in particolare ha varato da diversi mesi la “Agenda digitale 2020”: una policy specifica che interviene su tre driver di sviluppo e cioè infrastrutture abilitanti, valore dei dati ed empowerment delle persone. Soprattutto il primo di questi tre driver punta alla progressiva creazione di un vero e proprio ecosistema digitale turistico, in cui attrazioni turistiche, hub infrastrutturali, poli culturali e scientifici, ospedali e molto altro ancora siano messi a disposizione del turista. La Lombardia, per altro, un suo ecosistema digitale turistico già lo sta sperimentando. Il digitale viene in ultima analisi considerato non solo dal punto di vista del richiamo turistico, ma anche da quello dei servizi al turista.
Criticità e risorse disponibili
Ancora non sufficientemente sviluppato appare invece il livello di sensibilità per l’approntamento di progetti/prodotti turistici interregionali. Si stanno, è vero, cominciando a promuovere percorsi ciclabili, cammini, tours enogastronomici, ma non si rinvengono nei piani schemi operativi che invitano al superamento dei confini della singola Regione o provincia autonoma.
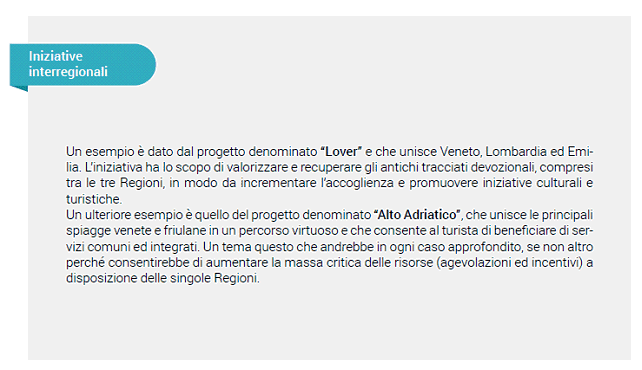
Ancora pochi dei percorsi volti a superare l’annoso tema della stagionalità. Faticano ancora a trovare spazio e premialità progettualità in cui destinazioni tipicamente stagionali (mare e montagna) concretizzano offerte turistiche complementari. Non si tratta solo di ridistribuire flussi turistici, quanto piuttosto di pensare a prodotti convergenti. In questo, per altro, potrebbe essere di aiuto una diversa e più compartecipata gestione dei grandi eventi e/o della congressualità, che possono più facilmente spalmare l’offerta turistica in modo trasversale.
Un altro grande tema che non trova se non una
blanda considerazione nei documenti analizzati è relativo alla
valorizzazione dei siti UNESCO presenti nei singoli territori. Stiamo parlando di 7 siti per il Veneto, 11 per la Lombardia, 5 per il Friuli-Venezia Giulia, 4 per l’Emilia-Romagna, 2 per il Trentino-Alto Adige. Tra questi siti segnaliamo la presenza di destinazioni trasversali e dunque compresenti in più Regioni (per tutti, Dolomiti e siti archeologici): circostanza che dovrebbe spingere maggiormente a lavorare su una progettualità macroregionale.
Quanto alle risorse finalizzate allo sviluppo del settore, queste comprendono fondi impiegati a bilancio delle singole Regioni, fondi che in regime di cofinanziamento riguardano la programmazione comunitaria per la strutturalità 2014-2020 e fondi nazionali destinati a valorizzazioni culturali e/o eventi di particolare importanza (es. Olimpiadi invernali 2021 a Cortina d’Ampezzo).
Per fare l’esempio del solo Veneto, nell’arco della programmazione comunitaria 2014-2020 le risorse direttamente impiegate per lo sviluppo del settore sono pari a circa 50 milioni di Euro sul solo POR parte FESR, cui vanno per l’appunto aggiunte quelle rinvenibili da bilancio regionale (per circa 10 milioni l’anno) e quelle attinte o attingibili da poste nazionali. In ultima analisi, una quantità di risorse significativa e da impiegarsi con coerenza rispetto alle traiettorie di policy individuate da ciascuna Regione. Sia pure da una lettura non certo analitica delle direzioni di spesa intraprese dalle singole Regioni, ci pare di poter affermare una certa coerenza tra le policy sviluppate e l’impiego delle risorse a disposizione.
Una conclusione
Quanto fin qui richiamato penso possa essere sufficiente a indicare quanto possa essere importante il turismo quale leva trasversale per lo sviluppo dei territori considerati e perché sia utile realizzare policy monitorabili dedicate al medesimo sviluppo.
Comprendendo in questo anche la dimensione problematica del turismo e che si esplicita soprattutto nella gestione dei flussi (impresa difficilissima in contesti particolari; si pensi alla emblematica situazione di Venezia) e nello sfruttamento delle stesse risorse naturali che ne costituiscono la linfa vitale. Basti tuttavia ribadire qui una considerazione e cioè che il territorio stesso, attraverso il suo storytelling e la visitazione turistica, diventa in termini di sviluppo futuro una risorsa e un prodotto: che deve avere una qualità riconoscibile e dunque un valore. Ragionare in termini di sviluppo macroregionale significa insomma fare i conti con il turismo e con le sue tante e nuove dimensioni.