Il contributo che segue è il frutto di una rilettura finalizzata al Rapporto della Fondazione Nord Est 2019 di una parte del primo Rapporto su Venezia Civitas Metropolitana, Quattro Venezie per un Nordest, scritto da un gruppo di ricerca della Fondazione di Venezia e in corso di pubblicazione.
Nell’introduzione al Rapporto Fondazione Nordest 2018, Carlo Carraro suggerisce di dare priorità negli investimenti infrastrutturali a scuole e università, a una rete digitale veloce e a basso costo e a ecosistemi d’impresa che favoriscano l’innovazione e l’avvio di nuove imprese, piuttosto che “a strade e ferrovie, idee spesso superate”. Non si può non convenire sulle priorità; un po’ meno - come vedremo - sul fatto che strade e ferrovie, ma anche porti ed aeroporti, siano superati in vista di quella “nuova competitività” che la Fondazione va cercando per il Nordest. Formazione di nuove competenze e nuova imprenditorialità innovativa innanzitutto, quindi.
Obiettivi necessari, ineludibili, per tenere il passo delle transizioni radicali - tecnologiche, ambientali, di globalizzazione dei mercati - che stanno trasformando il mondo a ritmi mai visti e ai quali l’Italia e il Nordest stentano a adeguarsi.
Ne conseguono differenze territoriali di ritmi e forme di cambiamento che possono mettere in crisi anche la più efficace strategia regionale di formazione di nuove competenze e di sostegno all’imprenditorialità innovativa. Possiamo investire con successo in scuola, università e ricerca, ma il tutto può venire frustrato - come sta avvenendo - dalla fuga all’estero dei migliori cervelli (un “estero” che per il Nordest può anche voler dire solo Milano o Bologna, visto che mentre il Veneto perde laureati Lombardia ed Emilia Romagna li attirano). Possiamo organizzare il miglior trasferimento tecnologico da università e centri di ricerca alle imprese, ma anche questo non impedisce che le attività più innovative lascino poi il Nordest per andare a svilupparsi in ecosistemi urbani - in Italia e all’estero - capaci di produrre le economie di agglomerazione che solo le metropoli sanno dare.

Quella metropoli che il Nordest e il Veneto che geograficamente potrebbe ospitarla hanno finora omesso di considerare uno strumento, un obiettivo intermedio necessario, del suo sviluppo. Un tema da riconsiderare con urgenza perché il “dove” dello sviluppo - le scelte localizzative di individui e famiglie - è questione che non si può trascurare in tempi di
disruption di ogni assetto economico e sociale che rende ogni attività più
footloose.
Non è questa la sede per riassumere i termini della querelle - che affonda le sue radici negli anni ‘60 dello scorso secolo - tra coloro che sull’onda del Progetto ‘80 (Ministero del Bilancio e della Programmazione economica - 1969), il solo esercizio di pianificazione territoriale strategica condotto nel nostro Paese dal secondo dopoguerra ad oggi, avevano identificato le città metropolitane, tra queste Venezia, delle quali dotare l’Italia e coloro che nel Veneto vi si sono opposti idolatrando il modello insediativo policentrico, a-gerarchico, l’altra faccia del “piccolo è bello” industriale – che giustificava ogni assenza di irrobustimento dimensionale delle imprese - e del
quieta non movere politico - che disobbligava dal dovere di “decidere”, di dare al Veneto e al Nordest la possibilità di appoggiarsi ad una gerarchia urbana e metropolitana proiettata sulla competizione col resto del mondo.
Il fatto è che oggi nel quadrilatero tra Milano, Monaco di Baviera, Lubiana e Bologna – i quattro tra gli 88
core urban nodes europei da connettere con la rete Ten-T che contornano il Nordest (figura 1) - non è presente un aggregato metropolitano degno di tale nome (perché tale non può ancora essere considerato quello - il solo possibile - organizzabile attorno al core urban node di Venezia e risultante dall’unione dei sistemi urbani giornalieri di Venezia, Padova e Treviso).
Manca a Nordest quell’aggregato insediativo, che chiamiamo metropolitano - che garantisca concentrazione e agglomerazione di “reti di imprese innovative, di lavoratori di talento, di imprenditori propensi al rischio, di istituzioni e di associazioni di sostegno che si raggruppano nelle aree metropolitane per co-produrvi risultati economici e progresso” (Katz, B. e Bradley, J., 2013). Una mancanza grave esaltata dalle caratteristiche della lunga crisi dalla quale stiamo uscendo e dalle trasformazioni radicali che stanno definendo la struttura produttiva protagonista della ripresa. Se
dalla Grande depressione siamo storicamente usciti con politiche nazionali di sostegno della domanda aggregata, dalla Grande recessione stanno uscendo vincenti solo quei Paesi che hanno investito su politiche di offerta a sostegno delle reti di “economie metropolitane” che stanno sostituendo “l’economia
nazionale [sia essa] americana (o cinese o tedesca o brasiliana)” (Katz, B. e Bradley, J., 2013). Le produzioni innovative tendono ad entrare “dall’alto” di ogni sistema insediativo “regionale” (civile e produttivo, che coincidono) per ridurre il rischio e godere delle economie di agglomerazione, per poi scendere di rango insediativo solo quando la standardizzazione del prodotto lo consente. L’indisponibilità di un aggregato metropolitano di taglia adeguata esclude l’intero sistema produttivo “regionale” - il nostro Nordest - dalla competizione globale per l’attrazione di imprese e produzioni innovative.
Oggi la “parte alta” del sistema insediativo del Nordest è quella rappresentata in figura 2 dove solo l’unione dei sistemi urbani giornalieri di Padova, Venezia e Treviso - che converrà chiamare Venezia Metropolitana per far godere a tutta l’area i vantaggi del marchio globale
Venezia - presenta le caratteristiche (oltre 1,5 milioni di abitanti; distanza “normale” dai nodi europei limitrofi; all’incrocio dei corridoi europei Adriatico-Baltico e Mediterraneo e facilmente raccordabile allo Scandinavo-Mediterraneo; nodo intermodale di rango europeo in quanto dotato, a Venezia, di aeroporto (Venezia e Treviso), porto marittimo e porto fluviale della rete centrale - con Chioggia porto fluviale della rete globale - e, a Padova, di terminale ferrovia-strada della rete globale) che l’hanno fatta considerare in sede europea una MEGA (Metropolitan European Growth Area) dedicata proprio al Nordest italiano.
Una Venezia Metropolitana - nel caso, la quinta area metropolitana italiana per dimensione - che, pur in assenza di politiche specifiche, o addirittura nonostante la legge n. 56/2014 recante
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, è andata evolvendo dal dopoguerra ad oggi come ogni altra area metropolitana al mondo riducendo (figura 3) il peso dell’occupazione manifatturiera a favore dei servizi non turistici, a Padova e Treviso, e di quelli turistici e non turistici a Venezia. Senza però che questo si sia ancora tradotto nello svolgimento di un preminente ruolo direzionale terziario e quaternario a vantaggio del Nordest: quello svolto da Venezia fino ai primi anni ‘60, ma poi disperso tra Venezia, Mestre, Padova e Treviso e, in misura maggiore, perso verso Milano.
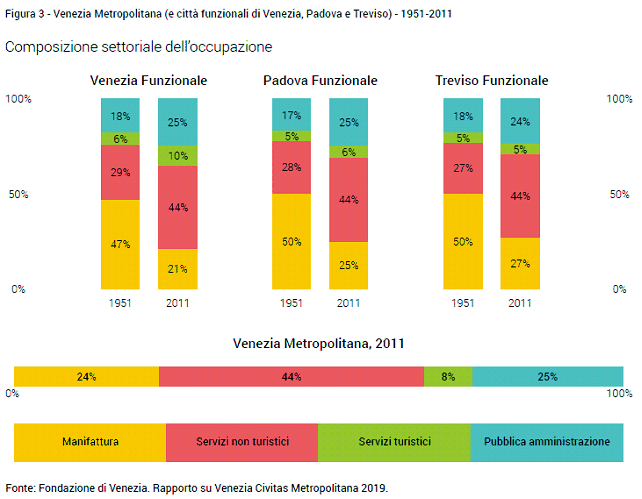
Venezia Metropolitana è dunque un aggregato territoriale che ha tutte le caratteristiche potenziali per svolgere le funzioni di motore di crescita del Nordest, di attrattore di talenti e di imprese innovatrici. Ma per diventare tale ha bisogno di evolvere da “città metropolitana nodale” (tripolare) a “città metropolitana di programma”, da irrobustire sistematicamente nelle funzioni di formazione e ricerca, foyers di cultura, strutture espositive, banche e assicurazioni, porti e aeroporti per l’interazione globale, etc.
Ma le città metropolitane moderne, e quelle grandi più delle altre, sono solo quello che le loro infrastrutture - ambientali, sociali e produttive (digitali, energetiche e di trasporto) consentono loro di essere (D’heilly, D. 2011). Sono solo livelli adeguati di infrastrutture che consentono ad una “città metropolitana” di crescere senza per questo perdere di efficienza produttiva e di qualità della vita. A questo fine le infrastrutture di trasporto non sono secondarie, e tanto meno superate, perché se le economie di agglomerazione sono una funzione della dimensione, questa e la concentrazione di ruoli superiori che esprime sono funzioni inverse dei costi di trasporto. Dai costi di trasporto, e dalle infrastrutture che li controllano, dipendono sia l’accessibilità esterna (l’area regionale di influenza della città
metropolitana) sia la connessione interna (il grado di interazione intrametropolitana).
Il ritardo nella “costruzione” della Venezia Metropolitana è evidente su entrambi i fronti. Le figure 4 e 5 mostrano, rispettivamente in negativo e in positivo, gli effetti sulla competitività relativa di Venezia Metropolitana del ritardo nel suo allacciamento alla rete dell’Alta Velocità/Alta Capacità (e quindi alla rete Ten-T). La figura mostra come l’Alta Velocità, la metropolitana (ferrovia) d’Italia come si autodefinisce, stia cambiando le relazioni iter-metropolitane (tra città) nel nostro Paese.
Con un evidente rafforzamento delle convenienze localizzative a Bologna e Firenze lungo l’asse Milano-Roma e la crescente periferizzazione del Nordest. Il passaggio allo standard AV/AC messo in dubbio sulla tratta Brescia-Padova della linea Venezia-Milano, mai proposto sulla Bologna-Padova, e addirittura miopemente rifiutato sulla Mestre-Trieste, rende plastica la riduzione della centralità di Venezia Metropolitana e, conseguentemente, della sua convenienza localizzativa delle attività direzionali, terziarie e quaternarie.
A contrario, la figura 5 mostra quale diventerebbe la zona di influenza propria di Venezia Metropolitana, e quindi di competizione con gli aggregati metropolitani contigui, qualora le tratte Milano-Padova, Venezia-Trieste e Padova-Bologna venissero dotate delle infrastrutture da Alta Velocità (treni viaggianti a 250 km/ora).
La possibilità di raggiungere Venezia in meno di due ore da Lubiana, Innsbruck, Milano e Firenze garantirebbe a Venezia Metropolitana la possibilità di contendere i vantaggi localizzativi delle MEGA confinanti di Milano, Bologna, Lubiana e Monaco di Baviera, con tutti i conseguenti effetti positivi per l’intero Nordest. Questo quanto all’accessibilità esterna.
Ma il potenziale di sviluppo di Venezia Metropolitana avrebbe altrettanto bisogno di aumentare la sua connettività interna, intrametropolitana.
Le aree metropolitane di domani non hanno nulla a che vedere con il modello monocentrico del continuum di periferie che soffocano un solo distretto centrale degli affari propri o della metropoli industriale. Anche le più̀ grandi aree metropolitane europee - Londra e Parigi per fare gli esempi più̀ noti - puntano ad un modello di grande città che deve essere:
1. multicentrica (per le attività̀ produttive, per i servizi e per le strutture per il tempo libero) e formata di vere comunità̀ locali;
2. fornita di un sistema di trasporti capace di collegare ogni punto A ad ogni punto B;
3. immersa nel verde;
4. governata da un sistema di pianificazione scarno ed agile (Hall, P. e Pain, K. 2006).
Venezia Metropolitana costruita sull’unione dei sistemi urbani giornalieri di Venezia, Padova e Treviso avrebbe molte delle caratteristiche ideali della grande città europea di domani. La mancanza di decisa preminenza nello scorso mezzo secolo di un solo polo urbano veneto (per la decadenza di Venezia non compensata dal lento irrobustirsi di Padova o di Verona), che può aver caratterizzato in negativo la situazione veneta di questi ultimi decenni, si trasformerebbe in un formidabile punto di forza. Ma a condizione che si realizzi il punto 2 delle regole dettate da Peter Hall: un sistema di trasporti capace di collegare ogni punto A (Venezia, Mestre, Padova e Treviso prima di tutti) ad ogni punto B (con priorità agli stessi). Una revisione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto orientato alla «costruzione» di Venezia Metropolitana contribuirebbe grandemente al fine comune.
Bibliografia
Hall, P. e Pain, K. (eds.) (2006) Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe London, Sterling, VA: Earthscan. David Pilling, Megacities, FT, nov.4, 2011.
Katz, B. e Bradley, J. (2013), The Metropolitan Revolution, Brookings Institution Press.
Ministero del Bilancio e della Programmazione economica (1969) Progetto 80. Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, Libreria Feltrinelli